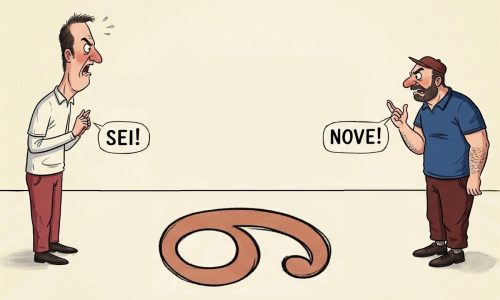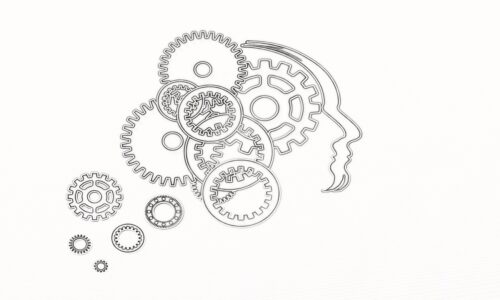Bias cognitivi e disturbi di ansia: come il pensiero alimenta l’ansia patologica
13 Ottobre 2025

Nel campo della psicologia, i bias cognitivi sono un argomento sempre più discusso, soprattutto quando si parla di disturbi di ansia.
Ma cosa sono esattamente e perché sono così importanti nella comprensione e nel trattamento dell’ansia patologica?
In questo articolo esploreremo come alcuni errori del pensiero influenzano il modo in cui vediamo il mondo e come possono alimentare l’ansia.
Cosa sono i bias cognitivi?
I bias cognitivi sono errori automatici e sistematici del pensiero che si verificano quando le persone elaborano e interpretano le informazioni provenienti dall’ambiente circostante, influenzando decisioni e giudizi.
Sono delle scorciatoie cognitive che, se da una parte aiutano a prendere decisioni velocemente, dall’altra possono risultare delle trappole mentali.
Infatti, i bias cognitivi sono in grado di distorcere la percezione della realtà di un individuo, con conseguente interpretazione scorretta delle informazioni e alterazione dei razionali processi decisionali.
Tutti noi siamo soggetti ai bias cognitivi.
Ad esempio uno dei più noti è il bias di conferma, ovvero la tendenza a cercare informazioni che confermano le nostre convinzioni.
Però, nei disturbi psicologici e in particolare nei disturbi di ansia, questi errori di pensiero diventano più rigidi e sistematici.
Numerose ricerche hanno evidenziato come i bias cognitivi contribuiscono a mantenere l’ansia patologica, impedendo alla persona di rielaborare in modo più funzionale ciò che accade.
Ma da dove originano questi bias?
Alcuni autori ipotizzano che derivino da sistemi di credenze di base incentrate sul pericolo e, pertanto, favoriscano in questa direzione un’elaborazione distorta delle informazioni sul mondo, su se stessi e sul futuro.
Questa elaborazione sarebbe, pertanto, filtrata da pensieri e immagini automatiche focalizzate sulla minaccia.
Tipi di bias cognitivi nei disturbi di ansia
Tre sono le principali categorie di bias cognitivi associati all’ansia:
- Bias attentivi
- Bias di memoria
- Bias di giudizio
Vediamoli nel dettaglio.
1) Bias attentivi: l’attenzione selettiva verso la minaccia

Le ricerche hanno ampiamente dimostrato la presenza di bias attentivi sia in soggetti con diagnosi di disturbi di ansia sia in soggetti non clinici con tratti ansiosi.
In questi campioni di persone si verifica un’attenzione specifica e controllata sugli stimoli di pericolo, per cui vengono selettivamente considerati gli stimoli negativi in un contesto generalmente positivo.
Ad esempio, una persona con disturbo di ansia generalizzata che ha eseguito un compito può prestare particolare attenzione a piccole correzioni, piuttosto che considerare l’insieme dei feedback positivi ricevuti.
Allo stesso modo, una persona con disturbo d’ansia sociale durante un’esposizione tende a focalizzarsi sul volto annoiato o di disappunto di qualche membro della platea, piuttosto che cogliere un generale e favorevole coinvolgimento del resto del pubblico.
Questo fenomeno è stato dimostrato sperimentalmente attraverso diverse tipologie di test.
Una di queste è il paradigma di Stroop.
In questo test ai soggetti vengono presentate delle parole scritte con colori diversi, alcune delle quali sono parole neutre (dette “di controllo”), altre fanno riferimento ad una minaccia.
Durante la prova ai partecipanti viene chiesto di nominare il COLORE con cui è scritta la parola e NON la parola scritta.
Quando ai soggetti ansiosi vengono presentate delle parole che si riferiscono ad una minaccia e viene chiesto loro di nominare il colore dell’inchiostro con cui sono scritte, la loro velocità di risposta è significativamente più lenta rispetto ai soggetti non ansiosi.
Un altro modo con cui i bias attentivi possono esprimersi è l’elaborazione automatica correlata alla minaccia.
In altre parole, un soggetto ansioso può esperire disagio senza averne piena consapevolezza verbale perché sta interpretando in forma automatica una situazione come pericolosa.
Questo accade di frequente nei soggetti con disturbo da attacco di panico i quali, senza rendersene conto e senza cosciente consapevolezza, si focalizzano sulla frequenza cardiaca con reazioni ansiose nel momento in cui avvertono una sua variazione, interpretata come segnale di anomalia.
Anche questo fenomeno è stato analizzato a livello sperimentale in studi dove vengono presentati stimoli di minaccia in forma subliminale, quindi al di sotto della soglia di rilevazione cosciente.
Rispetto ai soggetti di controllo, i partecipanti ansiosi si soffermano maggiormente sulla posizione spaziale delle parole negative presentate in modo subliminale.
Si è visto, inoltre, che quando le informazioni minacciose sono correlate alle personali preoccupazioni di un soggetto, i bias attentivi risultano più specifici per contenuto.
Ecco alcuni esempi:
- Una persona con fobia sociale, la cui preoccupazione attuale può riguardare la presentazione della tesi di laurea a porte aperte, può focalizzarsi sulle espressioni facciali della commissione e del pubblico, sul grado di distrazione dei presenti, sul livello di silenzio o di chiacchiericcio nella sala.
- Un soggetto con disturbo di panico che teme lo svenimento può concentrarsi su specifici segnali relativi al senso di concentrazione, di stabilità ed equilibrio o di acuità visiva.
- Chi soffre di disturbo ossessivo-compulsivo i bias attentivi coinvolgeranno i contenuti propri delle ossessioni di cui soffre (un ragazzo che si focalizza sul sorriso ricevuto da un uomo se teme di poter essere omosessuale).
2) Bias della memoria: cosa ricordano le persone ansiose?
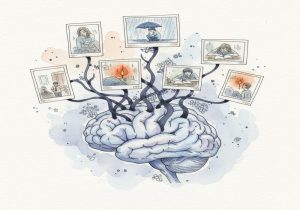
Gli studi sui bias di memoria nei disturbi di ansia hanno prodotto risultati incoerenti.
Alcune ricerche evidenziano come i soggetti ansiosi siano più propensi a ricordare informazioni legate al pericolo, altre non hanno riscontrato bias mnemonici.
Tale incongruenza è attribuibile al fatto che alcuni studi non distinguono tra memoria esplicita e memoria implicita.
Di che cosa si tratta esattamente?
La memoria esplicita fa riferimento al recupero consapevole di informazioni apprese in precedenza e viene esaminata di solito tramite test di richiamo libero o riconoscimento.
Un esempio di memoria esplicita concerne la lettura di un brano e la rievocazione intenzionale di quanto appreso. Oppure, il recupero volontario di un evento della propria vita che si vuole raccontare.
La memoria implicita rappresenta il recupero di informazioni apprese come effetto involontario di un’esperienza e viene testata indirettamente, senza chiedere di rievocare consapevolmente il materiale appreso.
Un esempio di memoria implicita riguarda, ad esempio, la guida.
Quando ci si mette in macchina non è necessario ricordare esplicitamente cosa fare, ma automaticamente e involontariamente si recuperano le informazioni che consentono di eseguire il compito.
Se teniamo conto di questa distinzione, le ricerche scientifiche suggeriscono che nei disturbi di ansia prevalgono bias di memoria implicita.
Secondo gli autori, nelle fasi iniziali di elaborazione le persone ansiose orientano la loro attenzione verso la minaccia, aumentando quindi l’accesso a queste informazioni.
Tuttavia, nelle fasi successive, tendono ad allontanare l’attenzione dalla minaccia, riducendo così il grado di recuperabilità di queste informazioni.
Per cui le persone ansiose mostrano una particolare vigilanza iniziale alla minaccia seguita, poi, dall’evitamento di una sua elaborazione, rendendo così le informazioni minacciose più accessibili, ma meno recuperabili.
Questa meccanismo si spiegherebbe con la funzione adattava dell’ansia: identificare rapidamente stimoli potenzialmente minacciosi, piuttosto che riflettere sugli eventi passati.
3) Bias di giudizio: la sovrastima del pericolo

Uno degli aspetti caratteristici dei disturbi di ansia è il bias di giudizio.
Il bias di giudizio consiste nel credere che gli eventi negativi siano altamente probabili o più probabili di quelli positivi.
I soggetti ansiosi, dunque, sovrastimano il rischio soggettivo di eventi negativi in modo più significativo rispetto ai non ansiosi, soprattutto se tali eventi riguardano loro stessi.
Questa stima distorta viene solitamente attribuita ad una euristica chiamata euristica della disponibilità: tendiamo a valutare la probabilità di un evento in base a quanto facilmente ci viene in mente un evento simile.
Essa è un processo di pensiero che non segue criteri di razionalità e che porta a giudicare la realtà in base alla frequenza con cui un evento si verifica intorno a sé.
Facciamo un esempio concreto:
se di recente sono state lette notizie su aerei che sono precipitati, saranno queste informazioni ad essere recuperate per fare una stima del tasso di incidenti, piuttosto che effettuare una valutazione statistica oggettiva.
Nei soggetti ansiosi si verifica una sovrastima della probabilità di un evento negativo perché in memoria ci sono eventi concernenti il pericolo più facilmente disponibili, simili a quello che si accingono a valutare.
Ma non è tutto: l’evento minaccioso sovrastimato non deve necessariamente assomigliare a quelli disponibili in memoria.
Infatti, possono verificarsi associazioni negative casuali che portano a stimare una maggiore probabilità di un evento negativo anche se non ci sono informazioni molto simili consolidate in memoria.
Questo processo è stato dimostrato sperimentalmente da alcuni studi dove venivano presentate una serie di prove in cui uno stimolo era associato in modo affidabile alla scossa elettrica e l’altro stimolo non era mai associato alla scossa elettrica.
I partecipanti dovevano valutare le loro aspettative sull’erogazione della scossa elettrica.
I soggetti con un elevato livello di ansia, a differenza dei controlli, avevano aspettative più elevate per le future prove di scossa elettrica anche per quelle configurazioni di stimolo che non erano mai state associate alla scossa elettrica.
Conclusioni: i bias cognitivi come bersaglio clinico
I bias cognitivi rappresentano uno dei principali meccanismi di mantenimento dell’ansia.
Non solo influenzano l’attenzione e la memoria, ma contribuiscono anche a giudizi irrazionali su ciò che potrebbe accadere, alimentando un circolo vizioso difficile da interrompere se non si interviene in modo mirato.
Sul piano clinico, considerato il loro ruolo nello sviluppo ed esacerbazione dei disturbi d’ansia, essi andrebbero inseriti tra i target del trattamento per minimizzare gli effetti potenzialmente debilitanti nel processo terapeutico e aumentarne, di contro, la sua efficacia.
Dott. Spinelli
Riferimenti:
– Muris P., Van der Heiden S. (2006). Anxiety, depression, and judgments about the probability of future negative and positive events in children. J Anxiety Disorders, 20(2), 252-61.
– Chen E., Lewin M.R., Craske M.G. (1996). Effects of state anxiety on selective processing of threatening information. Cognition and Emotion, 10(3), 225–240.
– MacLeod C., McLaughlin K. (1995). Implicit and explicit memory bias in anxiety: A conceptual replication. Behaviour Research and Therapy, 33(1), 1–14.